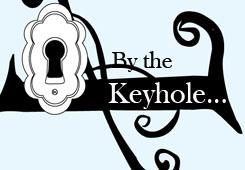
Pronti ad arricciare il naso? Questo mese Looking for books, la nostra rubrica dedicata ai classici, affronta un libricino che tutti abbiamo ritrovato tra i banchi di scuola e odiato - o, nel mio caso, amato. So che sentirete un brivido di terrore alla parola "verismo" e non posso non condividerlo, pur avendo molto apprezzato questo libro e pur essendo conterranea dell'autore di oggi, ma, superati i primi ostacoli, questo libro potrebbe davvero piacervi! Armatevi di coraggio e parliamo di...
Mastro-don Gesualdo
"Mastro don Gesualdo", attraverso le vicende di un muratore arricchito, narra la storia del rivolgimento sociale di una classe che decade e di una classe emergente, del travaglio e della rincorsa affannosa tra patrimonio e matrimonio. Tutta la grande letteratura siciliana ha raccontato il processo di questa crisi e di questo ribaltamento, da Verga a De Roberto sino al canto del cigno di Tomasi di Lampedusa. L'amore supremo per la roba, il sospetto e la difesa contro il prossimo sono le leggi inviolabili che guidano il comportamento di Gesualdo nel suo sforzo di conquistare una più degna posizione sociale. Ma quando si accorge che dovrà inesorabilmente lasciare tutto ciò che ha ammassato per una vita, Gesualdo si ammala senza rimedio. L'abbandono della vita equivale all'abbandono della roba e viceversa. Mentre si avvicina alla fine, il protagonista, sempre più solo, sempre più alienato, assume un'aura eroica e tragica.
Nato a Catania nel 1840, fu il massimo esponente del verismo. La sua prima formazione romantico-risorgimentale si svolse a Catania, dove abbandonando gli studi giuridici, decise di dedicarsi esclusivamente alla letteratura. Trasferitosi a Firenze nel 1865 compose i suoi primi romanzi Una peccatrice e Storia di una Capinera. Successivamente a Milano frequentò l'ambiente degli Scapigliati, rappresentando in modo fortemente critico il mondo aristocratico-borghese (Eva, 1873; Tigre Reale, 1873; Eros,1875). In seguito alla scoperta del naturalismo francese matura la sua svolta decisiva verso il verismo che sarà segnato dai racconti e dai romanzi di ambiente siciliano (Vita dei campi, 1880; I Malavoglia, 1881; Novelle rusticane, 1883; Mastro don Gesualdo, 1889). Lo scrittore crede nel progresso ma si interessa ai vinti e ai deboli; la sua è una visione della vita tragicamente pessimistica che si pone in antitesi con l'ottimismo imperante nei suoi tempi. Rappresenta un mondo di primitivi in lotta con il destino avverso cui inesorabilmente soccombono quando si staccano dalla religione, dalla famiglia e dal lavoro. Il linguaggio verghiano è arditamente innovatore: dando spazio al linguaggio dialettale riesce a raggiungere effetti di grandiosa coralità. Alla produzione narrativa si accompagnò quella teatrale, connotata sempre da una intensa drammaticità (Cavalleria rusticana, 1884; La lupa, 1884; In portineria, 1885; Dal tuo al mio, 1903). Lo scrittore muore nella sua città natale nel 1922.
[Fonte:
[Fonte:
Il sangue e la roba
Si potrebbe pensare di fare un torto a Giovanni Verga, se si asserisse che gli unici temi di un romanzo come Mastro-Don Gesualdo siano il “sangue” e la “roba”. Il romanzo non è infatti solo il racconto plausibile della vita di un uomo mai esistito, ma anche e soprattutto il quadro spietato di una Sicilia arida e venale, di un popolo tisico e ipocrita che trascina con sé i sintomi della fame e della miseria, e con questi affonda. Il “sangue” e la “roba”, tuttavia, sono i due nuclei, perfettamente amalgamati, attorno a cui agiscono i personaggi, in base alla quale vivono e prendono decisioni e grazie a cui, si potrebbe dire, nascono, crescono, e alla fine muoiono. Entrambi i microcosmi coesistono, si assemblano, si rincorrono fino all’ultimo rigo: il “sangue”, l’importanza della famiglia, dei legami parentali, l’orgoglio della stirpe, e la “roba”, termine dietro cui non si nasconde semplicemente il denaro, ma soprattutto l’accumulo delle terre, il desiderio di possedere e di non cadere in miseria. Questo, come già detto, è il binomio fondamentale, ma “Mastro-Don Gesualdo” è molto di più.
L’opera prende il titolo dal suo protagonista, un uomo arricchitosi grazie al sudore e alla fatica, divenuto un possidente invidiato dai suoi compaesani e tiranneggiato persino dalla famiglia, testardo e villano ma dal cuore generoso. Verga fa di lui un uomo vero e quasi palpabile, dotato di caratteristiche fisiche mai descritte ma facilmente intuibili. Vizzini, il paese in cui è ambientata la vicenda, è un luogo chiuso e circoscritto, caratterizzato da una società limitata e arrivista.
L’affetto che nutre Don Gesualdo per Isabella rappresenta l’altro fulcro della vita del protagonista: il sangue. E come lui, anche tutti gli altri personaggi lo chiamano continuamente in causa rivendicando i legami familiari per giustificare il pretesto di essere aiutati economicamente, o di aiutare a loro volta ipocritamente Gesualdo al fine di riceverne il suo favore e parte dell’eredità, come nel caso della sorella Speranza che si occupa di lui all’inizio della sua malattia e afferma “E’ sangue mio infine! Ora che è in questo stato mi rammento solo di essere sua sorella” e “Questo è il sangue vostro! Questi non vi tradiscono!”
La caratterizzazione del personaggio di Isabella, figlia del protagonista, è approfondita e a tratti narrata con poeticità. La ragazza, come affermato più volte all’interno del romanzo, non solo eredita le caratteristiche della famiglia, il “sangue” da cui discende –per esempio nel capitolo quarto della terza parte Verga la descrive: “essa l’aveva sempre lì nella ruga sempre fissa fra le ciglia, nella faccia pallida, nelle labbra strette che non dicevano una parola, negli occhi grigi e ostinati dei Trao che dicevano invece – Sì, sì, a costo di morirne!” – ma riflette anche in maniera speculare il modello di vita della madre, facendo le sue stesse scelte e subendo il suo stesso destino.
 Isabella, incinta del cugino Corrado La Gurna, sarà infatti costretta a sposare il Duca di Leyra e condannata ad un futuro da infelice, seppur circondata dagli agi e dal lusso. Bianca -che sposa Gesualdo per dare un padre alla propria creatura, di cui è già incinta al momento del matrimonio- allo stesso modo, nonostante gli anni alla fine l’avessero quasi avvicinata al marito, manterrà sempre una certa freddezza nei suoi confronti. Il legame che unisce i due sposi è di puro interesse, e la distanza tra la nobile decaduta e il povero arricchito appare incolmabile. Soltanto un episodio, poco prima della morte di Bianca, lascia trasparire un contatto leggermente più profondo, velocemente e volutamente interrotto però dalla donna. Isabella riprodurrà la scena, specularmente, con il padre appena prima della sua scomparsa.
Isabella, incinta del cugino Corrado La Gurna, sarà infatti costretta a sposare il Duca di Leyra e condannata ad un futuro da infelice, seppur circondata dagli agi e dal lusso. Bianca -che sposa Gesualdo per dare un padre alla propria creatura, di cui è già incinta al momento del matrimonio- allo stesso modo, nonostante gli anni alla fine l’avessero quasi avvicinata al marito, manterrà sempre una certa freddezza nei suoi confronti. Il legame che unisce i due sposi è di puro interesse, e la distanza tra la nobile decaduta e il povero arricchito appare incolmabile. Soltanto un episodio, poco prima della morte di Bianca, lascia trasparire un contatto leggermente più profondo, velocemente e volutamente interrotto però dalla donna. Isabella riprodurrà la scena, specularmente, con il padre appena prima della sua scomparsa.
Le figure femminili hanno dunque un ruolo predominante, quasi superiore a quelle maschili. Anche gli uomini, tuttavia, non sfuggono all’occhio severo e realista di Verga: un’attenzione particolare viene data alle figure minori e a ciò che rappresentano all’interno del contesto di Vizzini. Le chiacchiere che ruotano attorno alla figura di Don Gesualdo e l’invidia che suscita si concretizzano nella figura del barone Zacco e del canonico Lupi, che viene descritto come un personaggio astuto e a tratti viscido e che suggerisce a Don Ninì, uomo fatuo e vanesio, alcune azioni speculative sulle terre del comune.
Verga dissemina nel romanzo vari indizi sulla concezione che hanno i compaesani di Don Gesualdo, e ce ne rende partecipi sin dalla stesura del titolo. “Mastro-Don Gesualdo”, infatti, etichetta la figura del protagonista come quella di un uomo nato povero, mastro, e arricchitosi in seguito, diventando don. L’ambivalenza di questa condizione condannerà Gesualdo per tutta la vita, e sino alla morte. Nonostante abbia fatto il suo dovere aiutando i famigliari e i vicini –sebbene si mostri qualvolta implacabile nella sventura come nel caso di Don Ninì e non ceda alle preghiere della baronessa Rubiera- la sua morte è triste ed infelice.
Solo e divorato dal cancro allo stomaco, ripensando con aria nostalgica ai giorni passati, osserva, senza poter fare nulla, la dissipazione dei propri amati beni, sottolineando l’incapacità dei nobili di gestire il patrimonio. Pur essendo malato, egli ha sempre il pensiero ai suoi poderi che ora vanno alla malora, alla terra conquistata di cui conosce ogni zolla, a tutto ciò che ha messo da parte nel corso della sua vita e che ora gli viene brutalmente strappato, non solo dal genero, ma soprattutto dalla morte. La stessa presenza all’interno della casa della figlia non è dovuta ad un sentimento affettuoso, ma dalla volontà da parte del genero di estorcergli una delega che lo autorizzi ad amministrare i suoi averi. I natali umili di Don Gesualdo lo penalizzeranno persino nell’ora del suo decesso: disprezzato dal servitore che lo considera suo pari, se non inferiore, morirà senza possibilità di rivedere la figlia un’ultima volta, ignorato e degradato come una bestia.
E’ a questo punto che la potenza comunicativa di Verga esplode, tratteggiando, attraverso un punto di vista differente da quello finora utilizzato, la fine del protagonista.
Lo stile, essenziale ed asciutto, qualvolta poetico, arricchito di alcune espressioni dialettali, non risulta mai ridondante o altisonante. I toni e le espressioni patetiche utilizzate da Verga sono finalizzati alla descrizione degli stati d’animo di don Gesualdo in punto di morte, e delimitati a questo particolare momento. L’autore utilizza insomma lo stile più congruo al contesto che sta descrivendo, tralasciando il superfluo e dipingendo con crudezza e veridicità, sin dai primi tratti, l’ambiente siciliano. In questo modo Verga diventa uno scrittore universale, riesce a toccare il cuore del lettore senza giri di parole ma presentando semplicemente i fatti in tutta la loro nudità. L’abilità descrittiva, la caratterizzazione superba dei personaggi, la vicenda tragica e desolante fanno di “mastro-don Gesualdo” un romanzo indimenticabile ed una perla unica all’interno del panorama dei romanzi “siciliani”.
Il brano
Il brano che ho scelto è estrapolato dalla fine del libro, quando Mastro-don Gesualdo, anziano e ospite presso la figlia infelice (lei sarebbe stata la protagonista di un libro lasciato incompiuto da Verga, La duchessa di Leyra) vede la dote della donna dissipata e la sua povera roba in malora. Anche qui ricorre il tema del sangue ("Confidati a me che dei guai ne ho passati tanti, e non posso tradirti!"), fondendo in un testo brevissimo ma molto espressivo le due principali facce di questo romanzo.
"Povera roba!"
Talché don Gesualdo scendeva raramente dalla figliuola. Ci si sentiva a disagio col signor genero; temeva sempre che ripigliasse l’antifona dell’alter ego. Gli mancava l’aria, lì fra tutti quei ninnoli. Gli toccava chiedere quasi licenza al servitore che faceva la guardia in anticamera per poter vedere la sua figliuola, e scapparsene appena giungeva qualche visita. L’avevano collocato in un quartierino al pian di sopra, poche stanze che chiamavano la foresteria,dove Isabella andava a vederlo ogni mattina, in veste da camera, spesso senza neppure mettersi a sedere, amorevole e premurosa, è vero, ma in certo modo che al pover’uomo sembrava d’essere davvero un forestiero. Essa alcune volte era pallida così che pareva non avesse chiuso occhio neppur lei. Aveva una certa ruga fra le ciglia, qualcosa negli occhi, che a lui, vecchio e pratico del mondo, non andavan punto a genio. Avrebbe voluto pigliarsi anche lei fra le braccia, stretta stretta, e chiederle piano in un orecchio:
– Cos’ hai?... dimmelo!... Confidati a me che dei guai ne ho passati tanti, e non posso tradirti!
Ma anch’ essa ritirava le corna come fa la lumaca. Stava chiusa, parlava di rado anche della mamma, quasi il chiodo le fosse rimasto lì, fisso... accusando lo stomaco peloso dei Trao, che vi chiudevano il rancore e la diffidenza, implacabili!Perciò lui doveva ricacciare indietro le parole buone e anche le lagrime,che gli si gonfiavano grosse grosse dentro, e tenersi per sé i propri guai. Passa-va i giorni malinconici dietro l’invetriata, a veder strigliare i cavalli e lavare le carrozze, nella corte vasta quanto una piazza. Degli stallieri, in manica di camicia e coi piedi nudi negli zoccoli, cantavano, vociavano, barattavano delle chiacchiere e degli strambotti coi domestici, i quali perdevano il tempo alle finestre, col grembialone sino al collo, o in panciotto rosso, strascicando svogliatamente uno strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaiate, dei musi beffardi di mascalzoni ben rasi e ben pettinati che sembravano togliersi allora una maschera. I cocchieri poi, degli altri pezzi grossi, stavano a guardare, col sigaro in bocca e le mani nelle tasche delle giacchette attillate,discorrendo di tanto in tanto col guardaportone che veniva dal suo casotto a fare una fumatina, accennando con dei segni e dei versacci alle cameriere che si vedevano passare dietro le invetriate dei balconi, oppure facevano capolino provocanti, sfacciate, a buttar giù delle parolacce e delle risate di male femmine con certi visi da Madonna. Don Gesualdo pensava intanto quanti bei denari dovevano scorrere per quelle mani; tutta quella gente che mangiava e beveva alle spalle di sua figlia, sulla dote che egli le aveva dato, su l’A1lia e su Donninga, le belle terre che aveva covato cogli occhi tanto tempo, sera e mattina, e misurato col desiderio, e sognato la notte, e acquistato palmo a palmo, giorno per giorno, togliendosi il pane di bocca: le povere terre nude che bisognava arare e seminare; i mulini, le case, i magazzini che aveva fabbricato con tanti stenti, con tanti sacrifici, un sasso dopo l’altro. La Canziria, Mangalavite, la casa, tutto, tutto sarebbe passato per quelle mani. Chi avrebbe potuto difendere la sua roba dopo la sua morte, ahimé, povera roba!



Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per aver condiviso la tua opinione!