
Quando ho letto L'urlo e il furore, ho impiegato più di dieci giorni – metà dei quali a imprecare e cercare informazioni su internet per capire che acciderbolina stesse succedendo. Perché? Perché due sezioni su quattro – il libro è diviso in 4 giornate – sono incomprensibili. La seconda straordinaria sezione è piena di flussi di coscienza. La prima è scritta dalla prospettiva di un malato mentale. Immaginate.
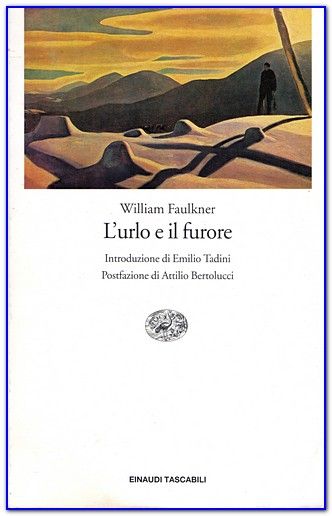
Poi, quando capisci, quando il quadro diventa chiaro – in teoria dovrebbe diventarlo definitivamente grazie all’appendice posta alla fine del romanzo, ma io ovviamente non potevo sclerare dietro ai personaggi senza capire a cosa si riferissero – si palesa la bellezza, la genialità, l’eclettismo di questo autore che riesce a tracciare la decadenza della famiglia Compson con tecniche ogni volta diverse e non meno stupefacenti. Sarà sperimentalismo – e grazie a Faulkner ho capito che non sarò pronta a Joyce prima di venti o trent’anni -, sarà complesso e talvolta irritante, ma, cavolo, questa è letteratura, quella che si rinnova, che non ristagna nelle classiche modalità, che non ti semplifica la vita, che ti sfida a capire, farti delle domande, e poi ti lascia così, sospeso, con i suoi personaggi straordinari, crudeli, abietti – che ti sono rimasti dentro, perché, dopo che leggi il flusso di coscienza di Quentin Compson, aspirante suicida a causa della sorella Caddy che ama, ma che è rimasta incinta di uno e sposerà a breve un altro, non puoi non sentirtelo rimbombare nella testa – e la sensazione è quella dello stupore: nonostante la tecnica che sembra essere intenzionata a non farti capire nulla, ricordi sorprendentemente ogni frase e ogni istante, e la storia è diventata un mosaico di prospettive, parole non dette, omogeneo nonostante tutto. La scena finale, l’urlo e il furore, è di un’epicità aggressiva, e in effetti il libro assume questi toni, da letteratura epica, tragediografia greca, in cui Quentin paga il pegno della sua hybris – l’amore per la sorella – con la morte, e Jason, la caricatura dell’uomo avaro, misogino e senza scrupoli, con la rovina.
E la stessa cosa è il tema dell’ereditarietà del destino – Quentin, figlia di Caddy così chiamata in memoria dello zio – che ricalca le sembianze e il percorso della madre – Puttana una volta, puttana per sempre, dice Jason. Dal quadro decadente degli Stati Uniti del Sud negli anni Trenta escono moralmente indenni solo i negri, Dilsey in particolare, la vecchia serva di cui Jason cerca inutilmente di liberarsi. E’ la sua prospettiva quella più limpida, più lirica, più comprensibile, bellissima e senza macchie. Faulkner è un trasformista tanto versatile che non si direbbe sia lo stesso autore che ha scritto tutte e quattro le sezioni. Il suo è un Nobel meritatissimo. Se, nonostante la fatica, un libro mi spinge a leggere altro dello stesso autore, significa che è andato al centro, che ha lasciato molto più di una storia: un’impronta chiara e visibile, impressa con forza, una malinconia aspra che colora gli occhi, anche se tutte le tinte vorrebbero mirare verso il cupo grigio e il nero.

Sosta in libreria da un po' di tempo e ho sempre sentito parere positivi!
RispondiEliminalo leggerò presto :D
Allorafammi sapere! :)
Elimina