
Come ogni fine anno, eccomi a fare il bilancio delle letture: ho varato in lungo e in largo la mia libreria Anobii, che questa volta conta venti libri terminati in più dello scorso. Il numero esatto è 80 e il caos degli ultimi tre mesi mi ha impedito di arrivare a 100. Il numero di pagine totali è 19.887, cioè una media di 250 pagine a libro. La qualità delle letture sembra migliorata rispetto allo scorso anno: cinque libri da cinque stelle, solo tre libri da una stella ma dieci da due stelle, mentre i libri valutati tre stelle sono stati trentatré e quelli a cui ho assegnato quattro stelle sono stati ventinove. Devo precisare che il confine tra tre e quattro stelle può essere stato talvolta labile e che in media le letture sono state buone, anche se non necessariamente eccellenti. I più curiosi potranno vedere, sotto, la foto con la lista degli ottanta libri letti quest'anno.
La parte più difficile del resoconto annuale è, però, quella in cui devo decretare i libri migliori e peggiori. Ho sempre assegnato una categoria a sé agli Young Adult perché, quando il blog è nato, ne recensivo diversi. Ormai però il motivo è andato venendo meno e, non a caso, le uniche tre stelle sono state assegnate a libri per giovani adulti. D'altro canto, sono stata costretta, per esclusione, a incoronare come Miglior Young Adult un libro a cui ho dato solo tre stelle e credo quindi che dal prossimo bilancio questa categoria sparirà, magari facendo posto a un'altra.
Da questa classifica che vede due estremi mancano, naturalmente, libri bellissimi che meriterebbero altrettanti elogi . Li cito qui per dare loro giustizia: Lolita, Le relazioni pericolose, La ragazza con l'orecchino di perla, Il dio del massacro, L'amante (Duras), Cecità, Non lasciarmi e i vari episodi di Una serie di sfortunati eventi. Ho letto più classici ma sono ulteriormente intenzionata, per il 2015, a eliminare libri con alta possibilità di prendere una e due stelle (e mi farebbe piacere togliere anche quelli da tre, che mi lasciano un senso fastidiosissimo di insoddisfazione, ma questo non è facilmente prevedibile). Vorrei fosse presente ancora più letteratura contemporanea, e per questo ho stilato la TBR 2015, che trovate in un'altra foto in basso. Come scrivevo su Instagram e sulla pagina facebook,
è, come mio solito, una tbr utopica: anche se quest'anno sono riuscita a leggere libri di 900 pagine, mettere nella stessa lista Il secondo sesso, Infinite Jest e L'Ulisse (io che da due anni ho in lettura I miserabili) è un suicidio. C'è da dire, comunque, che il 2015 sarà l'anno della mia laurea, quindi forse avrò qualche mese di stop per leggere, scrivere, curare il blog (anche in questo, forse qualcuno avrà notato che il mio impegno negli ultimi 12 mesi è stato più carente. Vorrei tanto avere un clone. Vi prego, regalatemi un clone). Sui 48 libri della TBR 2014, sono riuscita a leggerne ben 8. Nella TBR 2015 sono invece presenti 41 libri: 21 romanzi (colonna a sx) e 20 saggi (dx). Li ho scelti in base a due criteri: imprescindibilità e volumi che ho già in casa. Sono infatti quasi tutti libri che ritengo importante leggere e sono per intero libri che già posseggo e che non posso continuare a tenere lì - e poi la consapevolezza di aver oltrepassato i 100 libri ancora non letti mi sta facendo passare la voglia di comprarne di nuovi. Alcuni però sono eBook; insomma, ho bisogno di colmare lacune di capretta. Potrei anche stilare un'altra TBR parallela visto che, tra l'altro, questa è assolutamente insufficiente, ma già riuscire a leggere questi 41 sarebbe un miracolo.
Vi lascio quindi alla mia classifica e attendo di leggere la vostra :)
MIGLIOR LIBRO LETTO:
Sul miglior libro 2015 ci sono stati pochissimi dubbi. L'urlo e il furore, di cui trovate un breve commento QUA, è stato una lettura immensa. Malgrado la complessità dello stile, quasi interamente basato sul flusso di coscienza, è riuscito a farsi divorare e a farmi venire voglia di leggere altro dell'autore.

PEGGIOR LIBRO LETTO:
Come già detto, i tre peggiori libri sono stati tutti Young Adult. Dovendo variare la categoria ho quindi inserito questo libro da due stelle, anche se mi stanno venendo i dubbi sul perché sia stata tanto generosa. Le tematiche, sì, sono importanti e vorrebbero essere affrontate con leggerezza. Ma in realtà L'incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea è un coacervo snervante di luoghi comuni e banalità senza fine, che non è riuscito nemmeno una volta a strapparmi un sorriso e piuttosto è stato bravissimo a irritarmi e annoiarmi.
MIGLIOR CLASSICO:
Il premio come miglior classico va quest'anno a un libro che ho esitato troppo a leggere: La signora Dalloway. Un'altra esperienza con il flusso di coscienza, devo dire meno cervellotica e più rilassante, anche per le ambientazioni urbane e la personalità di Virginia Woolf che sento più affine di quella di Faulkner. Ho comprato l'edizione Feltrinelli tradotta e curata di Nadia Fusini, massima esperta dell'autrice inglese, e mi sono goduta un viaggio entusiasmante nei meandri psicologici della Woolf, rappresentati dagli alter-ego Mrs Dalloway e Septimus.

MIGLIOR YOUNG ADULT:
Come ho accennato, questa è una categoria che verrà depennata: è un po' inutile definire miglior Young Adult un libro che ho apprezzato molto relativamente. Di Raven Boys, che ha fatto scintille nel web, trovate la recensione QUI. Io l'ho trovato manchevole, seppur abbia apprezzato il tentativo di non rifilare ai lettori l'ennesima storia d'amore stucchevole.

PEGGIOR YOUNG ADULT:
Holly Black doveva essere la meraviglia delle meraviglie. La geniale, fantasiosa, originale autrice Young Adult. Anche no. Fate delle tenebre - e a me le fate neanche dispiacciono - è scritto così male ed è talmente pieno di buchi narrativi e cose totalmente prive di senso logico che, da un certo punto in poi, ho cominciato a soffrire durante la lettura. E si tratta di ben 665 pagine, che mi sono sembrate lunghe almeno il doppio. Nota per me stessa: se proprio devi leggere Young Adult, fallo a piccole dosi. Spararsi un mattone di questa roba non è stata decisamente una buona idea.
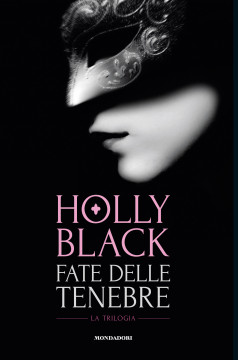
MIGLIOR ESORDIENTE:
Il miglior esordiente quest'anno è davvero, davvero, meritevole. L'autrice afropolitan Taye Selasi, come ho detto fino alla nausea anche QUI, è un mostro di scrittura. E' brava come una Holly Black non si sognerà mai di essere. Mi aspetto grandissime cose da lei, e il suo La bellezza delle cose fragili è decisamente sul podio dei migliori libri letti nel 2014.
LIBRO PIU' DELUDENTE:
Solo una domanda: perché? Di Paul Auster avevo letto L'invenzione della solitudine. Bello, elegante, profondo. Poi mi trovo davanti questi tre racconti gialli che formano Trilogia di New York: tematiche ancestrali, collegamenti internarrativi, misteri e indagini. Sembrava interessante.
E invece no.
Questo libro è stato, semplicemente, la noia. Roba che fa un baffo a Moravia e Brancati - maestri, loro - sul tema del nulla cosmico. Darò un'altra possibilità a Auster, ma questa cocente delusione non sarà presto dimenticata.
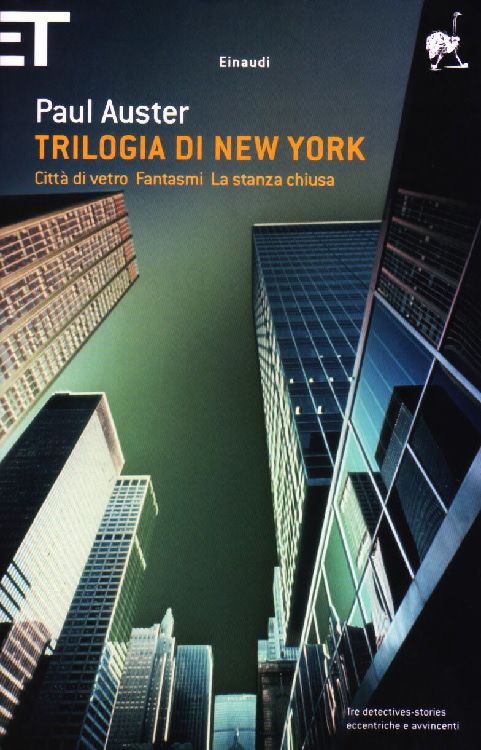
MIGLIOR SAGGIO:
Di saggi, quest'anno, ne ho letti pochini. Ma uno mi è proprio rimasto nel cuore: Perché scrivere di Zadie Smith. Sì, forse ha qualche difetto. Sì, certe volte l'autrice sembra un po' vaga. Ma è scritto meravigliosamente. E io, alle cose scritte così bene, non riesco proprio a dire di no.

 |
| Libri letti nel 2014. Clicca sull'immagine per ingrandirla |








