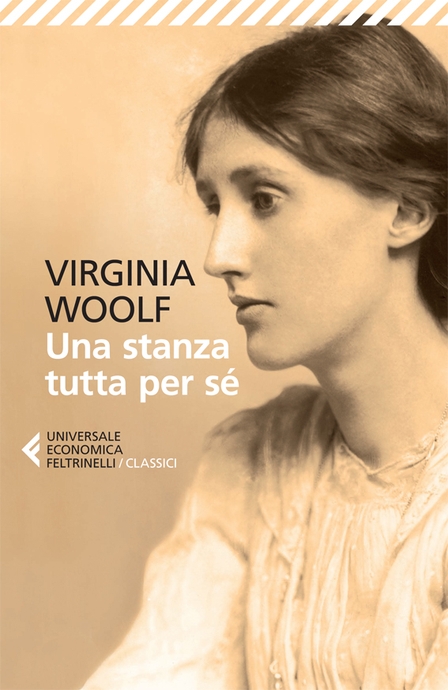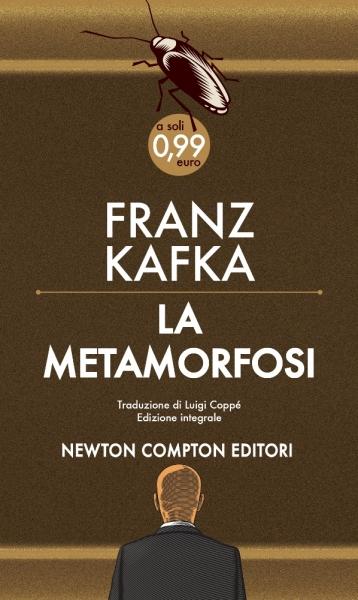In uscita oggi per
Adelphi, un titolo molto interessante: si tratta di una
raccolta delle epistole che il poeta e scrittore Carlo Emilio Gadda ha indirizzato a Pietro Citati, che fu il suo editor
presso Garzanti e riuscì a conquistare la fiducia del poeta che riusciva
magistralmente a combinare linguaggio e parodia. Questo volume, Un
gomitolo di concause, prende il suo titolo da ciò che Italo Calvino scrisse
dell’autore:
«Cercò per tutta la vita di rappresentare il mondo come un garbuglio, o groviglio, o gomitolo, di rappresentarlo senza attenuarne affatto l'inestricabile complessità, o per meglio dire la presenza simultanea degli elementi più eterogenei che concorrono a determinare ogni evento». (Lezioni Americane, pp.103-4)
Nell’epistolario (pagine: 239; prezzo: € 14,00) sono presenti interessanti riferimenti ad alcuni dei più importanti rappresentanti
della letteratura italiana del Novecento, un modo di riscoprire lo stile
sperimentale di Gadda, maestro della combinazione tra passione civile, sarcasmo
e psicologia freudiana, tipici della corrente espressionista.
Un gomitolo di concause
– Carlo Emilio Gadda
Nel
1956, allorché diventa consulente di Livio Garzanti, il giovane Citati non può
sospettare che gli verrà affidato un compito impossibile: occuparsi del più
impervio, moroso, nevrotico, geniale scrittore del Novecento, Carlo Emilio
Gadda. Rapidamente, Citati ne conquista la fiducia: e a questo miracoloso sodalizio
dobbiamo libri come il Pasticciaccio, I viaggi la morte, Accoppiamenti giudiziosi. Ma alle funzioni di editor Citati ne ha
ben presto aggiunte di ancor più delicate: quelle di confidente, consigliere,
amico e gaddista militante – in altre parole, di intermediario fra l’Ingegnere
e il mondo. Ne è prova il loro splendido carteggio, tutto da assaporare:
rassicurato dalla dedizione e dal veemente impegno in suo favore di Citati,
stimolato dalla vastità dei suoi interessi e dalla sua attività di critico,
Gadda rompe gli argini, si abbandona a lettere ‘esorbitanti’ e ‘barocche’, di
volta in volta eccentrici saggi, nobili poèmes
en prose, irresistibili bizze. Come quella, degna di Verso la Certosa, in
cui rievoca per Citati la sua mania di architettare mentalmente «case e ville e
castelli durante le lunghe camminate dell’infanzia e dell’adolescenza sugli
stradali prealpini, nelle ore d’una fuggente serenità». O quella, strepitosa,
in cui sfoga la sua rabbia contro Moravia e la Morante, colpevoli di averlo
«sfiancato, rintronato e vilipeso», durante una cena a Trastevere, con la loro
«cornacchiante erogazione di teoremi storiografici» – ossia con le accuse mosse
alle borghesie. Si capirà allora come mai Citati abbia scritto che in ogni momento
della vita di Gadda sembravano convergere «il passato ... il presente, il
futuro, la realtà, il sogno, il tragico, il comico, la colpa, il rimorso,
l’immaginazione, il gioco, la follia...».
Carlo Emilio Gadda
(1893 – 1973)
Nato
nel 1893 a Milano da una famiglia della media borghesia, compie nella città
natale i suoi studi, iscrivendosi nel 1912 alla facoltà di ingegneria del
Politecnico. Partecipa, volontario, alla prima guerra mondiale: fatto
prigioniero, trae dall'esperienza spunto per un “Giornale di guerra e di
prigionia”, che sarà pubblicato nel 1955. Laureatosi, svolge la propria
professione in Italia ed all'estero. Dal 1926, inizia a collaborare con la
rivista “Solaria”, per le cui edizioni escono “La Madonna dei filosofi” (1931)
e “Il castello di Udine” (1934), sue prime opere narrative. Nel 1940 si
trasferisce da Milano a Firenze e vi resta per un decennio: è del ‘44
“L'Adalgisa”, raccolta di racconti a carattere satirico sulla borghesia
meneghina dei primi del secolo. Dal 1950 è a Roma, dove lavora per un lustro ai
servizi culturali del terzo programma radiofonico: nel corso di questo periodo,
escono “Il primo libro delle favole” (1952) e “Novelle dal ducato in fiamme”
(1953), grottesco sul periodo terminale del fascismo. Nel 1957 (ma era già
apparso a puntate, su “Letteratura”, nel 1946-47), dà alle stampe il suo primo
capo d'opera, “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”. Adoperando
l'ossatura del giallo, Gadda compone uno straordinario ritratto dell'urbe
capitolina immersa nel clima di debilitazione morale e ferocia endogena
instaurato da Mussolini, “Il Facciaferoce col pennacchio, il Testa di Morto in
Feluca”: di assoluta originalità il linguaggio, che ibrida magistralmente vari
dialetti con lemmi e termini della lingua colta, in un impasto d'efficacia e
potenza ineguagliabile. Seguono i saggi, le divagazioni, le note a carattere
autobiografico riunite ne “I viaggi la morte” (1958) e “Le meraviglie d'Italia”
(1964), oltre a “I racconti. Accoppiamenti giudiziosi 1924-1958” (1963). Nello
stesso anno, compare in volume “La cognizione del dolore”(della quale su
“Letteratura”, tra il 1938 ed il 1941, si erano potuti leggere dei brani), che
si aggiudica il premio internazionale Formentor e viene accolta da entusiastici
giudizi della critica. Ambientata in un immaginario paese sudamericano che
lascia vedere in filigrana la toponomastica brianzola, la trama verte sulla
figura dell'hidalgo Don Gonzalo - trasparente proiezione dell'autore medesimo -
e del suo tormentato rapporto con la madre, altalenante fra il disprezzo ed una
dolente forma di affetto. Espresso con le consuete pirotecnie linguistiche, il
nucleo dell'opera risiede nel distacco dalla falsità della società
neocapitalistica, raffigurata nei vuoti riti dei “beati possidentes”, cui si
contrappone la pena figliata dalla consapevolezza, quel “male oscuro di cui le
storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre persistono a
dover ignorare la causa, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il
fulgurato scoscendere d'una vita, più greve ogni giorno, immedicato”. Tra i
molti lavori minori successivi, spicca “Eros e Priapo” (1967), folgorante
pamphlet sui miti del ventennio fascista. Nel 1973, all'età di ottant'anni,
Carlo Emilio Gadda si spegne a Roma.

.png)